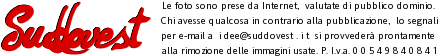CARO STEFANO, IL FASCISMO? ALTRO CHE LA BESTIA TRIONFANTE! di Pepi Burgio
 Caro Stefano, rinuncio volentieri ad inserirmi nella vexata quaestio circa l'antifascismo e l'anticomunismo, che bordeggia ormai la speciosità e la stucchevolezza, e provo ad aggiungere qualcosa al tuo scoppiettante ragionamento, certo stimolante e ritmato come sempre dall'incalzare della brillantezza di una retorica che forse, in qualche caso, richiederebbe piombo e zavorra.
Caro Stefano, rinuncio volentieri ad inserirmi nella vexata quaestio circa l'antifascismo e l'anticomunismo, che bordeggia ormai la speciosità e la stucchevolezza, e provo ad aggiungere qualcosa al tuo scoppiettante ragionamento, certo stimolante e ritmato come sempre dall'incalzare della brillantezza di una retorica che forse, in qualche caso, richiederebbe piombo e zavorra.
Che il fascismo si definisca esclusivamente per "odio tribale, disprezzo settario", mi sembra faccia il paio con la premessa da te posta quando scorgi in esso l'incarnazione della "innata disposizione umana alla prevaricazione e al sopruso". Magari!
La storia del '900, cumulo insignificante di rovine, ha conosciuto il volto feroce di idee assassine originate in ambiti culturali e politici fra di loro molto diversi; ma ugualmente vocate allo sterminio di una classe (comunismo) o di una razza (nazismo), con le propaggini mostruose dei massacri senza scopo, peraltro già praticati ampiamente quattro secoli prima nel "nuovo mondo" dai conquistadores cattolici spagnoli.
Ritenere, come tu ritieni, che la "brama di potere e l'ansia di sottomissione" siano tare su cui il fascismo possa esercitare una sorta di royalty, di rivendicazione monopolistica è uno strano sillogismo poiché sovraccarica oltremodo uno sciagurato fenomeno storico, deprecabile e tragico quanto si vuole, di connotazioni veterotestamentarie, metafisiche.
Nell'intervento è inoltre contenuta un'affermazione difficilmente accoglibile, dal momento che da più di mezzo secolo gli storici più attenti e lucidi (De Felice, Gentile, Vivarelli etc.) hanno tra l'altro contrastato la tesi secondo la quale nel fascismo non vi sia "nulla di culturalmente originale o inedito". Cominciamo dal cosiddetto programma di Piazza S. Sepolcro a Milano nel 1919, luogo di fondazione dei fasci di combattimento: esso prevedeva fra l'altro la riduzione della giornata lavorativa a otto ore, la partecipazione dei lavoratori alla gestione tecnica delle imprese, la riforma fiscale con l'imposta progressiva sul capitale, il sequestro dei beni delle congregazioni religiose, la necessità di abbracciare la pratica del radicalismo rivoluzionario e dell'anticlericalismo ispirandosi al sindacalismo rivoluzionario e al mito della violenza che nella dottrina politica di Sorel trovavano la più compiuta teorizzazione. La vera novità era però costituita dalla strategica, irrinunciabile rivendicazione di uno Stato corporativo pensato come superamento dell'economia di mercato di stampo liberale e del collettivismo socialista, accanto alla esaltazione nazionalista antidemocratica ed antiparlamentare. Ricordo a me stesso, a proposito del diffuso ed esplicito ricorso alla violenza come strumento indispensabile di lotta politica, che nello stesso identico scorcio storico della fondazione dei fasci di combattimento, il partito socialista massimalista annunciava nel nuovo statuto del 1919 la necessità di instaurare anche in Italia, con la violenza, la dittatura del proletariato. A sottrarsi a tale letale suggestione furono, come risaputo, soltanto i liberali ed i cattolici, estranei alle turbolenze del biennio rosso.
Ma tornando alla novità rappresentata dal corporativismo, idea-forza rimasta poi sostanzialmente, come del resto alcune altre, lettera morta nel corso del consolidamento del fascismo-regime, va sottolineato che la "verità" del fascismo va rinvenuta nel suo rapporto con le masse mediante il quale riuscì a realizzare una politica inclusiva, motivante, moderna, sempre finalizzata, lo ricorda lo storico Roberto Vivarelli, a integrarle nel tessuto nazionale. Lo stesso Palmiro Togliatti, nelle Lezioni sul fascismo del 1935, pur incorrendo nel comprensibile abbaglio di giudicare la dittatura di Mussolini un regime reazionario, colse tuttavia il suo carattere sociale, di massa. Trent'anni dopo, il magistero scientifico esercitato dagli studi sul fascismo di Renzo De Felice e dei suoi allievi, fu impegnato a dimostrare, tra i mal di pancia degli accademici e dei sommi sacerdoti della vulgata resistenziale, che il fascismo, a differenza dei sistemi autoritari e reazionari ottocenteschi, o dei regimi dittatoriali della seconda metà del '900, nella Grecia dei colonnelli e nel Cile dell'oppressione militare del generale Pinochet, tesi alla "demobilitazione delle masse, alla loro sola partecipazione passiva al regime", ebbe come elemento distintivo la partecipazione e la mobilitazione di queste.
Il principio ispiratore del fascismo fu quello della partecipazione attiva e non dell'esclusione, certo nelle forme demagogiche, paternalistiche e talvolta grottesche di un "totalitarismo imperfetto", secondo la nota definizione di De Felice; cioè non compiuto, realizzato soltanto parzialmente, tanto da non poter meritare, per cosiddire, stante la sua menomazione ontologica, di essere annoverato nell'analisi compiuta da Hanna Arendt, accanto al totalitarismo sovietico e a quello nazionalsocialista.
Va aggiunto inoltre: se è vero che il fascismo non si ispirò ad alcun apparato dottrinario definito, ciò però conferma il suo carattere moderno, liquido diremmo oggi, o antideologico, secondo Emilio Gentile; il quale allude al primato dell'azione politica, alla consapevole necessità di acquisizione del consenso mediante il controllo sistematico della stampa e soprattutto degli allora moderni mezzi di comunicazione di massa, quali la radio e il cinematografo, cui si annetteva importanza strategica al fine di pervenire alla "totale risoluzione del privato nel pubblico". Ed è anche per questo che far coincidere il fascismo con lo squadrismo violento e sanguinario, significa precludersi alla comprensione della complessità del fenomeno e adagiarsi nella sterile riproposizione di una sloganistica utile soltanto alla cattiva propaganda politica.
Anni fa Marco Pannella sosteneva a ragione che nella intelligenza di Giovanni Gentile, Alfredo Rocco, Gioacchino Volpe, Giuseppe Bottai, risiedesse la vera pericolosità del fascismo con lo svilimento del liberalismo, della democrazia e del socialismo; e non già "nel brutale uso della forza" di mozzaorecchi, mazzieri avvinazzati, pendagli di forca della pianura padana. Scrive Mussolini il 13 agosto del 1921 a proposito dello squadrismo: "Se noi continueremo a distruggere le camere del lavoro senza una precisa ragione, susciteremo l'odio, perché offenderemo una larga cerchia di interessi materiali e morali".
In conclusione, caro Stefano, non trovo opportuno, alla luce delle acquisizioni storiografiche ormai da tempo consolidate, individuare nel fascismo la rispondenza ad un istinto prepolitico, o a "una rivoluzione regressiva nel nome della bestia che è in noi"; se non abbassandosi a quelle forme di fascismo generico osservate da Emilio Gentile che consiglia vivamente di attenersi ad una necessaria cautela, onde evitare i rischi di scivolare verso interpretazioni che risolvono la complessità del fascismo entro rappresentazioni, nel tuo caso come al solito accattivanti e seducenti, ma a una sola dimensione.
La semplificazione della storia, diceva quel tale, ne inibisce la conoscenza.
Un caro abbraccio, Pepi.