“PIETRE BILIARI” : UN'INDOMABILE ARSURA DI SPERANZE di Pepi Burgio
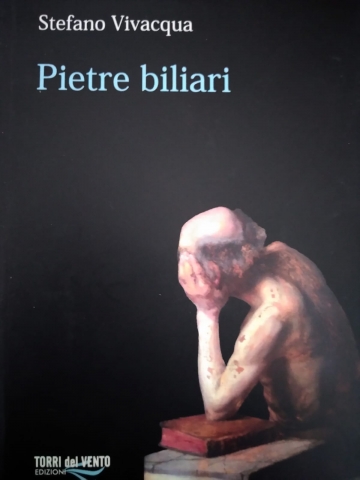 Sarà perché, lo ricorda l’autore con Flaiano, neanche la morte ci interessa più, tanto in ritardo arriva sulla familiare confidenza che con essa abbiamo intessuto, ma in ogni caso, ciò che mi turba e mi commuove della nuova pubblicazione di Stefano Vivacqua, è la perfetta misura nel racconto di quei momenti indicibili della nostra vita affettiva, in cui le parole facilmente scadono nel consolatorio, nello spudorato, nell’irrispettoso.
Sarà perché, lo ricorda l’autore con Flaiano, neanche la morte ci interessa più, tanto in ritardo arriva sulla familiare confidenza che con essa abbiamo intessuto, ma in ogni caso, ciò che mi turba e mi commuove della nuova pubblicazione di Stefano Vivacqua, è la perfetta misura nel racconto di quei momenti indicibili della nostra vita affettiva, in cui le parole facilmente scadono nel consolatorio, nello spudorato, nell’irrispettoso.
Donna ineffabile mia madre, di monumentali ingenuità e granitiche certezze. Ricordo le sue ultime parole, qualche ora prima dell’ultimo respiro. Improvvisamente sbarrò gli occhi e mi fissò. Le chiesi come stesse, e lei, che già da giorni non comunicava più, inaspettatamente rispose spaventata: “Ho perso le tracce di me stessa”. Ha richiuso gli occhi e ha taciuto per sempre. Povera mamma, fu la prima volta che la vidi smarrita, atterrita, dopo una vita di spavalde cavalcate sulle sue dogmatiche illusioni. Devo a lei quel che sono stato, e a mio padre quel che sono diventato. La quiete dopo la tempesta, proprio così, il distacco disincantato dal mondo dopo la passione permalosa per i sogni.
E così allora “Pietre biliari”, in parte almeno, mi appare, al diavolo i generi, la continuazione di alcune pagine de “Il complesso di Atlante”: l’accorata descrizione dell’ineffabile mitezza del padre, che non desiderava nient’altro se non un po’ di silenzio, una sedia, qualcosa da leggere, e il sapere che noi stavamo bene; e l’atmosfera evocata dal racconto della visita ai nonni paterni, nella prima metà degli anni sessanta, nella piccola patria d’origine, Ravanusa, contesa tra “Lascia o raddoppia” e la campagna intorno, dove col buio, ben visibili, erano ancora le lucciole.
Ricordo le sere d’inverno… il grande braciere al centro della cucina, noi tutt’intorno, affumicati e mezzo addormentati, zia che annuncia “li lietti su pruonti”, per dire che ha già messo gli scaldini sotto le lenzuola; la foto-ritratto dello zio morto, enorme, sinistramente illuminata da una pavida candelina elettrica la cui lucetta era la miglior complice delle tenebre nel diffondere lo spavento nella stanza; il mio lettino nella parete che guarda lo zio, e le notti passate ad immaginarmi come si muore fulminati in campagna, sotto un albero infame, in una qualunque di quelle sere che cominciano e finiscono tutte uguali, con i padri e i fratelli che tornano a casa a memoria di mulo. E al risveglio il gelo, colate invisibili di gelo che impetrano le cispe degli occhi, e il latte bollente che sa di selvaggio, io che ci soffio dentro, tremante, per togliere il velo del caglio che mi fa schifo; e la montagnola di chicchi di frumento in soffitta, alta fino al tetto, e io che mi ci tuffo dentro [...].
Ma “Pietre biliari” è soprattutto altro: pensieri, riflessioni, aforismi, suggestioni, svolte ora con rigore cartesiano, ora con intuizioni profonde e paradossali, spesso intinte in una amarezza sconfinata. Cioran? Sì, certo anche Cioran, a tratteggiare il fondale su cui l’autore allinea i fantasmi che scuotono la sua esperienza vissuta; estetica e quindi necessariamente dolente.
Siamo onesti, non è forse vero che gran parte del genere umano procrea a danno dei figli?
Se c’è una cosa vera, è che i figli non ci hanno chiesto di venire al mondo. Se c’è una cosa probabile, è che anche loro sconteranno lo stesso abuso.
Caduto in disuso il terrore dell’inferno, cos’altro rende la vita preferibile alla morte in ogni caso, se non il vizio assurdo dell’autocommiserazione?
Ho cominciato ed ho continuato a leggere “Pietre biliari” secondo modalità ordinarie e con cadenze compulsive: esattamente il contrario di quanto prescritto dai cultori del genere, che per comodità definiamo aforistico. Ma ciò non mi ha impedito di apprezzarne, uno in particolare, radicalmente antiumanista e lirico ad un tempo. Vorrei proporlo: Ammiro gli alberi, ne invidio la flemma, la taciturna operosità, il fatalismo con cui resistono ai venti e al tempo che li piega. Solo è ciascun albero, e fa da solo, e niente lo smuove. E tante cose vede e sente, che tiene per sé. E niente chiede in cambio della sua premurosa ombra, e dei frutti che elargisce. La sua presenza non è mai invadente, la sua ospitalità è senza sforzo né ricompensa, e perfino le sue scorie sono alimento per la vita, fermento di rinascita. E’ il vivente più saggio e dignitoso che esista, e in un’altra vita vorrei essere come lui.
Non manca nulla a questo libro perché vada a collocarsi fra quelli che continuano ad alimentare, nonostante tutto, un’indomabile arsura di speranza. Semmai c’è qualcosa in più, ma chi se ne intende, Federico Roncoroni per esempio, sostiene che ogni aforisma oltre a contemplare la malinconia e l’ironia, lo scetticismo e il cinismo, deve saper parlare anche il linguaggio umoristico.
Un’ultima cosa: spero di abbracciare al più presto Stefano e ringraziarlo per questa ulteriore dimostrazione di sensibilità e di intelligenza. Se poi avrà la pazienza di ascoltarmi, vorrei dirgli di un francese del ‘600 e di un danese di due secoli fa. Male non gli farà. Anch’io, si parva licet, come Giovanni Raboni, pur non vivendo alcuna fibrillazione fideistica, mi ritengo interno ad una tensione, ad un sentire problematico, ad un tenere i conti aperti con quella dimensione che Stefano avversa in maniera militante. Anch’io, si parva licet, come Raboni, sono fondamentalmente un non-ateo.

